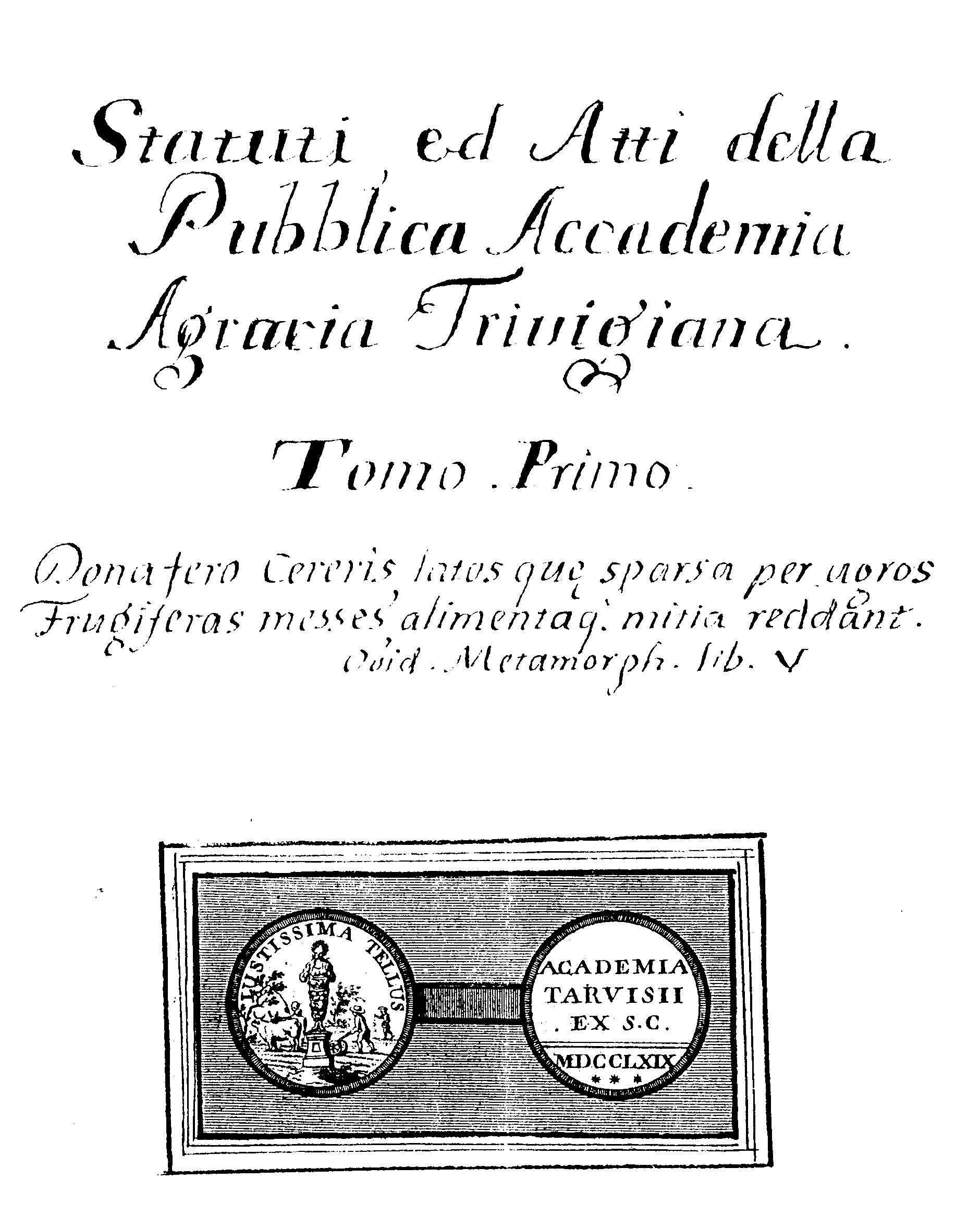Porta la data del 12 settembre 1768 la lettera che il doge Alvise Mocenigo diresse al podestà di Treviso con la quale sollecitava l’istituzione di una Accademia Agraria e che fu seguita il 10 dicembre successivo dall’invito ufficiale del Senato Veneto alle Società culturali della Terraferma di trasformarsi in tal senso sull’esempio di quella di Udine sorta nel 1762.
Aderirono all’invito del Senato Veneto nel territorio trevigiano Treviso, Conegliano ed Oderzo le cui attività poi furono attive fino alla caduta della Repubblica nel 1797.
Conosciuta la necessità di dare l’avvio ad una rinascita economico finanziaria per risollevare l’agricoltura ed incrementare per quanto possibile specialmente la specie bovina e l’allevamento degli ovini, Venezia non trovò partita migliore della istituzione delle Accademie Agrarie e ciò nelle tracce abilmente sperimentate da tante altre estere nazioni.
Per promuovere le utili scoperte e maggiormente estendere studi ed esperienze, nonché assicurare anche la sua sussistenza, era d’uopo che, accolta nelle sovrana protezione, venisse pure dotata di un anno di emolumento, nell’utilissima sua destinazione.
Il Senato Veneto dunque, aderendo alle suddite richieste, con suo decreto 24 febbraio 1789 stabilì per l’Accademia Agraria di Treviso un annuo assegno di 150 ducati valuta camera.
L’attività di questa Accademia, insieme con altre due di Conegliano e Oderzo fu feconda, con scambio di soci nei dibattiti e nelle relazioni.
A Conegliano tra gli altri si segnalarono il conte Vinciguerra VIII di Collalto, Francesco M. Malvolti e il conte Pietro Caronelli fondatore dell’Accademia, così come ad Oderzo lo fu il conte Ascanio Amalteo nel 1795, decorato del diploma di georgofilo di Firenze.
Uomini altrettanto illustri sulla campestre economia onorarono l’Accademia Agraria di Treviso come Domenico Zambenedetti, Marco Fassadoni, Vittore Gera, Marcantonio Rizzi, Angelo N. Talier ed altri molti.
Che l’opera dell’Accademia Agraria di Treviso sia stata di grande utilità lo rileviamo lo stesso anno della caduta di Venezia dal rapporto steso dal Comitato alle finanze, arti, commercio, acque ed agricoltura di Treviso.
Sotto la data del 9 nevoso dell’anno primo della libertà italiana, il 29 dicembre del 1797, incaricato di “promuovere ed incoraggiare con ogni mezzo possibile le arti tutte e principalmente l’agricoltura che ne è la madre e la nutrice”, il Comitato così decise:
“Tutte le istituzioni che tendono alla pubblica felicità e vantaggio hanno un immediato diritto di stima, ed alla preferenza di chi presiede. Esse formano l’ornamento d’una città, la misura delle sue risorse, il genio degli abitanti, e l’elogio più onorevole della medesima. Tra le più utili e commendevoli va senza dubbio collocata l’Agricoltura. Essa mette tra le mani della Nazione ricchezze vere e durevoli, alla quali sola può dare un corso pacifico e continuato. Se però tra i pesantissimi oggetti che nelle attuali vicende interessarono questa provvida Municipalità, non si è ancora pensato a riconfermare e ristabilire solidamente l’Accademia Agraria, che direttamente la riguarda, crede questo Comitato di dover per brevi istanti chiamarla a versare su questo importante istituto, che nuovamente organizzato sopra un piede stabile e fisso, potrà coi suoi lumi e benemerite ricerche promuovere la nazionale industria ed acquistarsi un diritto alla pubblica riconoscenza ed estimazione in vista però tutto l’esposto propone il seguente decreto: La Municipalità Provvisoria decreta che in vista di quanto il Comitato Finanze ha col suo rapporto informata questa Municipalità sia ristabilita l’Accademia Agraria”.
Ispiratore di questa determinazione si presume sia stato l’abate Angelo N. Telier, arciprete di Campo di Pietra, già socio e censore della stessa Accademia, membro del Governo Municipale, acceso sostenitore dei francesi e noto per il discorso tenuto in piazza San Marco a Venezia, il 7 giugno del 1797, quando fu alzato l’albero della libertà.
Purtroppo i successivi avvenimenti frustrarono le sagge proposte del Comitato e il passaggio degli eserciti stranieri, gli immancabili guasti, i saccheggi, le imposizioni di guerra, le requisizioni di grano, vino, foraggi, bestiame da parte dei francesi e degli austriaci, immiserirono le popolazioni, paralizzarono per molti anni i commerci, determinarono la chiusura definitiva della benemerita Accademia Agraria non più attiva dal 1797 e con essa, anzi prima erano state sciolte le altre di Conegliano e di Oderzo.
Gli studi dei singoli accademici che testimoniano il fervore e le iniziative prestate negli ultimi anni di vita della Repubblica di Venezia sono in parte pubblicati nel Giornale di Milocco, nel Nuovo Giornale d’Italia e nel Nuovo Giornale del Perlini ma molti risultano perduti.
Nel corso di dieci anni dalla cessazione delle Accademie Agrarie, la provincia trevigiana non ebbe più alcuna istituzione culturale.
Il 3 febbraio 1807, un anno dopo la fine della prima dominazione austriaca andata dal 2 gennaio 1798 al 25 dicembre 1805 con la breve parentesi di tre mesi nel 1801 al tempo della Cisalpina dal 16 gennaio al 13 aprile, usciva il Monitor di Treviso, settimanale di grande interesse locale seguito poi dal Giornale del Dipartimento del Tagliamento, a seguito del decreto 27 novembre 1811 il cui programma, oltre agli Atti ufficiali di Governo, si proponeva di divulgare le nuove scoperte utili alle scienze ed alle arti, in particolar modo relative all’agricoltura, alla pastorizia, sotto la direzione dell’arciprete di Postioma Giuseppe Monico, letterato ed erudito. Un foglio che segnò un’epoca di rinascita culturale, un foglio di grande diffusione.
Quanto ad associazioni culturali nel 1807 sorse il Gabinetto di Lettura che tre anni dopo si fuse con la Filodrammatica ma col 1811, il 6 dicembre, il Gabinetto di Lettura fu trasformato in Ateneo di Treviso.
In seguito al decreto 25 dicembre 1810, articolo 17, dietro invito della Prefettura (Ordinanza prefettizia n.2688 del 20 febbraio) comunicata dal podestà di Treviso al Gabinetto letterario con lettera n.639 stesso giorno, il segretario perpetuo di questa associazione Gaspare Ghirlanda iniziò la pratica per erigerla in Ateneo, cioè in una società di uomini dotti della provincia divenuta, con modifica dei confini, Dipartimento del Tagliamento e a questo appartenenti per origine o per domicilio.
Non pare che dalla sua fondazione e per gli anni relativi al dominio austriaco iniziato il 2 novembre 1831, l’Ateneo di Treviso sia vissuto col contributo dello Stato.
In una minuta di lettera senza data ma probabilmente del 1820, indirizzata dal presidente in carica dell’Ateneo all’Imperiale Regia Commissione Liquidatrice del Debito Pubblico con sede in Milano, si chiede il ripristino dell’assegno annuo cessato con la caduta della Repubblica di Venezia e dunque quando ancora non esisteva l’Ateneo, come dire che l’istituzione si riconosceva discendere direttamente dall’Accademia Agraria. In tutti quegli anni a detta del presidente dell’Ateneo di Treviso, il Corpo accademico si era mantenuto in attività “sicuro che una volta o l’altra sarebbe stato provveduto alla mancatagli dotazione.” A conclusione della lettera si legge: “Il presidente dell’Ateneo di Treviso quale rappresentante della concentrata Accademia Agraria, risultando creditore, dietro la fatta esposizione, di Lire 13.800 italiane ammontare di anni 23 di emolumento dal 1798, a tutto l’anno 1820, in ragione di Lire 614 annue inerendo al prescritto dalla Sovrana Patente 27 agosto 1820, insinua questo credito onde riportare quegli effetti che sono dalla Patente contemplati.”
Se ne deduce dunque che l’Ateneo di Treviso dal 1810, data di costituzione, al 1820 era vissuto economicamente col solo contributo dei suoi soci, come dire che il Regno Italico aveva sì promosso l’istituzione culturale, l’aveva sì riconosciuta legalmente ma mai era intervenuto per sostenerla economicamente né più né meno come si era sostenuto in modo autonomo il Gabinetto Letterario con contributi mensili ammontanti ad un fiorino oltre a sei di buon ingresso.
L’Ateneo però, tranne poche lezioni accademiche di argomento agrario, aveva avviato la propria attività su argomenti di più ampia e varia informazione culturale e non esclusivamente di agricoltura.
Il Governo del Regno Italico è vero che tentò di risollevare le sorti dell’agricoltura cercando di dare impulso agli studi cessati dopo la chiusura delle Accademie Agrarie, che con l’apertura del Liceo Dipartimentale istituì una cattedra di agricoltura e botanica affidata all’abate Pietro Molin di San Vito al Tagliamento, che diede corso a questa importante disciplina di studio, che realizzò nel 1810 un orto botanico grazie all’abate Nicolò Giani succeduto al Molin e che promosse l’istruzione agraria ai contadini incaricando i parroci a tenere le lezioni.
E’ anche vero che il Governo emanò norme e istruzioni valide per le leggi sanitarie, le epizoozie, gli scoli e la bonifiche, l’avocazione al Demanio dei beni immobili delle soppresse Corporazioni Religiose, lo svegro dei boschi nelle località montane e tante altre disposizioni, ma l’Ateneo di Treviso non seguì se non in minima parte quanto la cessata Accademia Agraria aveva affrontato nel campo dell’attività agricola in netto anticipo sugli altri paesi del territorio veneto e cioè l’istruzione agraria il loco ai contadini.
Questo lodevole e provvidenziale insegnamento era stato avviato, sotto la Repubblica di Venezia, con notevole intuito dal socio dell’Accademia Agraria Melchiorre Spada, arciprete a Fossalunga di Vedelago che primo tenne le sue lezioni in chiesa ai suoi parrocchiani dopo le funzioni religiose per cui la soppressione dell’Accademia fu un grave danno perché non permise, se non in pochi limitati casi ai contadini ed ai titolari di terreni di promuovere miglioramenti sostanziali nei loro poderi, rinnovare abitazioni e stalle malsane e abbandonare metodi di coltura superati.
E’ certo che ai nostri giorni l’istituzione di una Accademia Agraria, diretta continuatrice dell’antica e con le stesse ambizioni di rinnovamento e aggiornamento, esclusivamente orientata ai problemi agricoli locali, troverebbe vantaggi considerevoli ed approvazioni generali del settore perché alimenterebbe il fervore di iniziative che l’Ateneo di Treviso mai ha dato pienamente e non potrebbe francamente dare.
15 agosto 2001
Giorgio Renucci
Bibliografia
- Statuti e Atti dell’Accademia Agraria di Treviso, in Archivio dell’Ateneo di Treviso, II, 37r.
- Raccolta di memorie delle pubbliche Accademie di agricoltura, arti e commercio dello Stato Veneto, Venezia, Perlini, 1789-1796.
- M. Lecce, L’Agricoltura veneta nella seconda metà del Settecento, Verona, 1958.
- Accademia Aspiranti e Agraria, in Archivio Comunale di Conegliano, Buste 428, 429, 430.
- G. Navosa, Memoria sull’origine ed istituzione dell’Accademia letterario-georgica degli Aspiranti dei Conegliano, Ceneda, 1808.
- L. Crico, Elogio di Melchiorre Spada arciprete di Fossalunga, in Memorie scientifiche e letterarie dell’Ateneo di Treviso, Treviso, Andreola, 1817.
- G. Renucci, La cultura a Treviso durante il Regno Italico (1805-1813), in Bollettino Italiano di Studi Napoleonici, Barbera, Firenze, II, 5, giugno 1963, pp. 25-36.
- G. Renucci, L’attività degli studi agrari nel Dipartimento del Tagliamento, in Rivista Italiana di Studi Napoleonici, Berbera, Firenze, V, 13, febbraio 1966, pp. 7-20 e in Atti del primo e secondo Congresso internazionale di Studi Napoleonici, Firenze, Olschki, 1969, pp. 424-436.
- G. Gullino, Le dottrine degli agronomi e i loro influssi sulla pratica agricola, in Storia della Cultura Veneta, Il Settecento, Venezia, Neri Pozza, 1986, pp. 379-410.